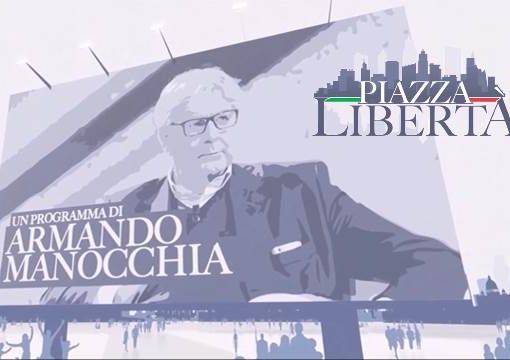Lâora X dellâEuropa: la guerra come algoritmo. Bruxelles sta centralizzando la paura e industrializzando la fine della pace
di Carmen Tortora (https://sfero.me/ora-x-europa-guerra-algoritmo) – LâUnione Europea non sta âprevenendoâ la guerra: la sta programmando, riga dopo riga, come si scrive un codice sorgente. Ogni direttiva, ogni fondo, ogni task force è un frammento di software che prepara il continente non a disinnescare il conflitto, ma a gestirlo come un processo produttivo.
Nel linguaggio anestetizzato dei commissari, il progetto si chiama âReadiness 2030â. Nella realtà , è una mobilitazione permanente travestita da integrazione. Non più eserciti nazionali, ma unâunica macchina militare europea, controllata da un cervello burocratico senza volto.
La vecchia Europa delle cattedrali è diventata unâEuropa di capannoni: fabbriche di munizioni, di droni, di polveri e di ordini esecutivi. Tutto rigorosamente âverdeâ e âsostenibileâ, naturalmente – perché anche la guerra, oggi, devâessere eco-compatibile.
Il linguaggio della pace, la logica della guerra
Bruxelles ama parlare di âautonomia strategicaâ. Ma dietro la semantica neutra si nasconde unâoperazione chirurgica: la rimozione del potere nazionale.
Con lâEDIS (European Defence Industrial Strategy), approvata nel 2025, la Commissione si è attribuita il diritto di pianificare la produzione bellica dei 27 Stati membri come se fossero reparti di una sola fabbrica.
Nel White Paper for European Defence â Readiness 2030, si legge che lâobiettivo è âassicurare il coordinamento centrale della capacità industriale in caso di crisiâ. Tradotto: in guerra, Bruxelles decide chi produce, cosa produce e per chi.
Un potere che nessun parlamento ha mai votato.
Dietro la vetrina della cooperazione si nasconde la più grande centralizzazione di potere economico e militare nella storia europea moderna.
Il SAFE (Support for Ammunition and Firearms Enterprises) e il programma ASAP (Act in Support of Ammunition Production) sono i due bracci armati di questa tecnocrazia bellica.
ASAP – ironia del nome – finanzia la costruzione di impianti per munizioni e polveri âil prima possibileâ. SAFE, con fondi BEI e garanzie pubbliche, mantiene in vita un circuito industriale che non deve più rispondere al mercato ma alla paura.
Non è un âpiano per la difesaâ. à un piano per il controllo totale della produzione, un nuovo COMECON militare con il logo blu stellato al posto della falce e martello.
La corsa agli arsenali: lâEuropa si riarma in silenzio
Nel 2022 le fabbriche europee producevano circa mezzo milione di colpi da 155 mm lâanno.
Oggi, grazie ai programmi ASAP, Rheinmetall, Nammo, Thales e BAE Systems promettono di arrivare a 2 milioni di colpi entro il 2026.
à un moltiplicatore di morte quattro volte superiore in soli quattro anni.
E Bruxelles applaude.
In Germania, Rheinmetall ha aperto nel 2025 la nuova fabbrica di UnterlüÃ: 350.000 colpi lâanno, espandibili.
In Romania, con 600 milioni di euro di fondi pubblici e privati, sta sorgendo una megafabbrica di polveri – la più grande dâEuropa dal 1945.
In Lituania, un nuovo impianto sarà operativo nel 2026.
La Polonia ha stanziato 2,4 miliardi di zloty per tre stabilimenti nazionali; la Francia ha riconvertito parte del complesso Nexter; persino la Finlandia ha rianimato la vecchia linea Nammo di Lapua.
LâEuropa non costruisce scuole o ospedali âcomuniâ: costruisce linee di produzione di artiglieria.
E chi si ostina a chiamarlo âpiano di difesaâ è complice di una menzogna semantica.
Perché una fabbrica di munizioni non difende nulla: serve solo quando si spara.
Dalla democrazia alla direzione centrale
Nessuno ha chiesto ai cittadini europei se desiderano vivere in uno Stato di guerra tecnocratica.
Eppure, le strutture giuridiche per farlo sono già scritte.
Il Preparedness Act, ispirato al Defense Production Act statunitense, permetterà alla Commissione di dichiarare unâemergenza âeconomico-strategicaâ e di assumere il controllo diretto della produzione civile.
Un interruttore giuridico che trasforma lâeconomia di mercato in economia di comando.
Le industrie potranno essere obbligate a convertire linee produttive, le infrastrutture energetiche potranno essere razionate, e le normative ambientali sospese.
Il tutto senza bisogno di votazioni parlamentari.
Il Readiness 2030 prevede inoltre un European Defence Industrial Board, una sorta di Politburo dellâindustria bellica, composto da rappresentanti della Commissione, della BEI e dei giganti privati del settore.
Un cartello perfetto: la burocrazia fornisce le regole, le aziende forniscono le armi, e i governi forniscono il silenzio.
Lâillusione della deterrenza
Si parla di âdeterrenza autonomaâ, ma il termine è un eufemismo per âmobilitazione incompletaâ.
Secondo Bruegel e il Kiel Institute, servirebbero 300.000 nuovi soldati e 250 miliardi di euro annui per garantire una difesa credibile.
Nessun paese è disposto a spenderli, ma tutti fingono di crederci.
Le scorte europee di munizioni durerebbero due settimane in una guerra vera. Le difese aeree multilivello esistono solo nei PowerPoint della NATO.
Eppure, Bruxelles si comporta come se bastasse un regolamento per vincere un conflitto.
La RAND Corporation, nei suoi report del 2025, avverte che âla piena integrazione delle supply chain militari europee aumenta il rischio di collasso sistemico in caso di attacco informatico o sabotaggio logisticoâ.
In altre parole: un solo colpo su un hub ferroviario o un cavo dati potrebbe paralizzare tutta la macchina.
Ma la Commissione risponde con il suo mantra: âcentralizzare per essere più resilientiâ.
à come rinforzare una diga concentrando lâacqua da un solo lato.
Gli scenari del rischio
Il 2025 sarà probabilmente un anno di tregua apparente: 5â10% di probabilità di conflitto diretto, secondo RAND e Belfer Center.
La Russia è ancora impegnata in Ucraina, ma i segnali di logoramento strategico spingeranno Mosca a testare la NATO.
Il 2026 vedrà lâintensificarsi di sabotaggi e attacchi ibridi: blackout, cyberwarfare, destabilizzazione energetica.
Il momento cruciale arriva però tra il 2027 e il 2029, quando la macchina europea sarà pronta solo a metà .
LâUE avrà fabbriche nuove di zecca, ma non abbastanza scorte; avrà procedure unificate, ma nessun comando politico reale.
à in questa finestra che il âtest di coesioneâ diventa plausibile: unâincursione limitata nei Paesi baltici o un attacco simultaneo a infrastrutture critiche.
Lo scopo non sarebbe conquistare, ma umiliare lâEuropa: mostrare che può essere paralizzata in tre giorni.
Se lâUE reagisse con lentezza, la deterrenza crollerebbe.
Se reagisse con impulsività , lâescalation sarebbe immediata.
à la trappola perfetta: costruita non dal nemico, ma dalla nostra architettura decisionale.
Dopo il 2030, il rischio si trasforma in certezza condizionata.
Se il Readiness Plan fallisce, se i ritardi burocratici persistono, la probabilità di conflitto supera il 50%.
Non unâinvasione, ma una guerra a cerchi concentrici: sabotaggi, crisi energetiche, destabilizzazione politica e guerre per procura nel Mediterraneo.
Il sogno di âautonomia strategicaâ si dissolverebbe in una nuova forma di dipendenza totale dal sistema che la produce.
Centralizzare la vulnerabilitÃ
Il più grande errore dellâEuropa non è la lentezza: è la fede cieca nella centralizzazione come panacea.
Si crede che accorpare competenze e poteri renda più forti, ma in guerra la ridondanza salva le civiltà , non lâefficienza.
Un attacco a un server strategico di Bruxelles, a un centro dati o a un hub ferroviario – e la âdifesa europeaâ tornerebbe allâetà della pietra.
à lâeffetto collaterale dellâinformatizzazione totale: la sicurezza diventa un algoritmo, e lâalgoritmo ha un tasto di spegnimento.
RAND lo definisce ârisk of systemic paralysisâ: la fragilità nascosta dietro lâinterconnessione.
Ma il paradosso è che proprio questo rischio è ciò che giustifica altra centralizzazione, altri fondi, altre emergenze.
Ogni vulnerabilità genera una nuova direttiva, ogni direttiva crea un nuovo potere, e così lâUnione diventa ciò che dice di temere: un Leviatano digitale vestito da burocrazia benevola.
La fortezza senza popolo
In apparenza, lâEuropa si prepara alla difesa. In realtà , si prepara al controllo.
Un continente che trasferisce il potere di guerra a organismi non eletti, che finanzia la produzione di armi con fondi pubblici e che sospende le regole democratiche âin nome della sicurezzaâ, non si sta difendendo: si sta chiudendo dentro.
à la nascita di una fortezza burocratica, con porte automatizzate e cittadini schedati per âresilienzaâ.
La pace diventa un file di progetto, la guerra un protocollo di attivazione.
La differenza tra guerra e governance si assottiglia fino a sparire.
E quando il meccanismo sarà completo – intorno al 2030 – nessuno potrà dire dove finisca la difesa e dove cominci la repressione.
Perché un sistema capace di mobilitare industrie, risorse e cittadini in nome della sicurezza esterna, può farlo altrettanto bene contro i propri.
LâEuropa non rischia solo la guerra: rischia di diventare la guerra.
Un continente che centralizza tutto – fabbriche, dati, catene di comando, decisioni – finirà per centralizzare anche la paura.
E la paura, come la polvere da sparo, ha una data di scadenza.